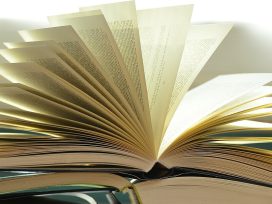1.
Un esercito immenso vagola, smandriato per il mondo. Le statistiche lo segnalano in cifre, ma quelle sono panoramiche. I senzalavoro costretti al furto, alla prostituzione, al suicidio, al mercenarismo poliziesco o militare sono legione innumerevole. I lupi, solitari e timidi, si fanno, con la fame, solidali ed aggressivi. Gli uomini vanno, isolati e vinti, in cerca della zuppa filantropica o dei noleggiatori di schiavi. Su chi rivendica il diritto alla vita anche i ventri affamati ruttano il crucifige!
Non vi è ragione di disperare. La sfiducia negli uomini è un veleno del quale occorre svelenare noi stessi e quanti altri sia possibile. La sfiducia è la giustificazione che inganna la nostra presunzione; le nostre viltà, l’animale attaccamento alla vita. Quando si giunge a dire gli uomini non meritano, è la dignità umana che si bestemmia, è il sogno più bello della nostra generosità che si rinnega, è la diserzione non solo dalla lotta per tutti che si accetta ma è anche la rinuncia a qualunque disciplina morale.
Camillo Berneri, I tempi nostri e noi
Alcuni dati.
Oltre 2 miliardi di persone vittime di fame e malnutrizione (FAO).
Le guerre in corso sono 29. I morti, dal 1990 al 2007, sono stati circa 6 milioni, più della metà nella guerra del Congo (ONU).
I bambini-soldato sono circa 500.000 (Unicef).
I bambini sfruttati nel mercato del lavoro sono quasi 250 milioni, di cui fra i 12 e i 20 milioni in condizioni di schiavitù (OIL e Anti-Slavery).
I bambini sfruttati dal mercato della prostituzione sono almeno 3 milioni (Unicef).
Negli ultimi 10 anni, circa 10.000 emigranti sono annegati fra le coste africane e quelle dell’Italia meridionale.
Questo accade al giorno d’oggi, ai tempi nostri. Accade anche altro, ma ciò che abbiamo elencato con impassibilità statistica dovrebbe avere la priorità. Ancor più se esistesse una memoria attiva di ciò che accadde ai tempi di Berneri, quando il fascismo e lo stalinismo erano ormai consolidati, il nazismo prendeva il potere, il razzismo antisemita diventava sempre più violento, la crisi economica spingeva verso un’altra guerra mondiale – che cominciò in Spagna, dove Berneri morì, nel 1937, ucciso da sicari stalinisti mentre combatteva il fascismo. Le “democrazie liberali” si rassegnarono alle “necessità dell’economia” che le avevano già fatte rassegnare al fascismo e al nazismo, i movimenti politici filosovietici si rassegnarono alle “necessità della storia” che li avevano già fatti rassegnare al regime stalinista. Entrambe queste rassegnazioni si disposero al sacrificio contingente delle dittature e della guerra in nome del progresso, poiché il procedere verso il meglio comporta ogni tanto qualche battuta d’arresto, qualche regresso. Sappiamo che cosa accadde dopo.
Ciò che dovrebbe avere la priorità può anche averla, a tratti, nei discorsi dei potenti e nei palinsesti dei massmedia, ed anche nei discorsi e nei pensieri degli uomini. Non di tutti. Chi subisce le forme estreme di povertà e di violenza non può astrarre dalla propria condizione contingente. Ciò che per noi dovrebbe essere prioritario, nei pensieri e nei discorsi, per chi ne è vittima è l’unica realtà possibile: non può scegliere, non può “decidere della propria vita”, poiché della sua vita hanno deciso altri, decidendo che la sua vita è irrilevante, un numeretto in più nel conteggio dei “perdenti”, un nulla.
E qui, per cominciare ponendo sùbito una questione dirimente, si manifesta la principale fra le contraddizioni rimosse dell’ideologia dominante, poiché si diceva e ancora si dice, nelle parole della propaganda, che il mercato libero garantisce libertà e democrazia offrendo “uguali opportunità” a tutti. Nei fatti, le opportunità diventano sempre più disuguali e, per non lieve paradosso, affinché tutti potessero partire dalla stessa posizione nella “corsa al profitto” occorrerebbe, prima, rendere il mondo egualitario. Da questa menzogna di base ne discendono un’infinità di altre, che soltanto risalendo alla prima possono essere arginate. Dal rimuovere le differenze nella condizione di partenza discendono rimozioni tali da offuscare anche i più profondi pensieri sull’odierna “condizione umana”, poiché non esiste una “condizione umana” generale se non considerando, innanzi tutto, la condizione di chi subisce la violenza dell’economia e delle armi. Che gli uomini “non imparino mai”, che si trasformino facilmente da vittime in carnefici (esemplari, in questo, le aggressioni in Sudafrica agli immigrati dallo Zimbabwe e dal Mozambico), se può indurre al pessimismo antropologico anche più cupo, non esime dal porsi domande sul contesto in cui il “non imparare mai” si ripresenta, sul conflitto permanente che predomina e sul quale vanno riaffiorando, fortemente incitati dalle “istituzioni”, soprattutto in Italia, razzismi e fascismi (e stalinismi, certo, magari in forme abiette di solidarietà con la Cina, ovvero con il paese in cui totalitarismo “comunista” e “libero mercato” si sono alleati proponendo e prospettando un “modello vincente” per tutto il pianeta).
Tra gli obbiettivi del millennio indicati dall’ONU nel 2000, al primo posto c’era “lo sradicamento della povertà estrema e della fame”. Aver scelto la parola “millennio” è sintomatico. Così, il termine di realizzazione degli obiettivi può arrivare fino all’anno 3.000, anche se la soglia temporale è stata fissata al 2015. Ma il Rapporto del 2007 già deve riscontrare una certa “lentezza” e una scarsa coerenza, nei potenti della Terra, fra il dichiarare e il fare. Poiché “in the Millennium Declaration of 2000, world leaders set forth a new vision for humanity… Leaders committed themselves to spare no effort to free our fellow men, women and children from the abject and dehumanizing conditions of extreme poverty’. We must recognize the nature of the global trust at stake and the danger that many developing countries’ hopes could be irredeemably pierced if even the greatest anti-poverty movement in history is insufficient to break from business as usual’.” Dunque, sarebbe possibile “sradicare la povertà estrema e la fame” in quindici anni. Un tempo brevissimo, calcolato non da ottimisti impenitenti ma dai “tecnici” degli organismi internazionali. Era già accaduto. Nel Rapporto del 1990, la Banca Mondiale aveva prospettato la possibilità di dimezzare il numero dei poveri estremi entro il 2000. Nel 2000 i poveri estremi erano invece quasi raddoppiati, e non solo a causa dello “sviluppo demografico”. I tempi brevi prospettati dalla Banca Mondiale nel 1990 e dall’ONU nel 2000 hanno tuttavia un fondamento. Infatti, per eliminare la povertà basterebbe investire il dieci per cento di ciò che viene speso in armi. Basterebbe anche ridistribuire un poco la ricchezza. Basterebbero, insomma, pochi spiccioli. Eppure, di decennio in decennio, l’obiettivo si sposta in avanti, sempre più avanti, verso un futuro la cui radiosità sembra illuminare soltanto le coscienze di chi dovrebbe “donare”, di chi, potendo agire, comunque non agisce, ma promette promesse che non sono “debiti” e che forse fanno sentire buoni i promettenti. “In futuro”.
David Rothkpof, del Carnegie Endowment for International Peace, che collabora con quotidiani come il Wahington Post e il Financial Times, ha recentemente pubblicato Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making. Federico Rampini, in “la Repubblica” del 21 giugno 2008, così ne sintetizza il contenuto: “la metamorfosi della finanza internazionale è stata una delle tendenze portanti di quest’epoca. In un quarto di secolo i flussi di capitali sono diventati immensi, istantanei, e controllati da una nuova razza di trader che rappresentano un manipolo di colossi finanziari concentrati in pochissimi paesi. Le loro remunerazioni personali hanno polverizzato ogni precedente storico: il manager più pagato di uno hedge fund nel 2007 ha intascato da solo tre miliardi di dollari. La concentrazione di potere è cresciuta a dismisura. Le 50 maggiori istituzioni finanziarie controllano 50.000 miliardi di dollari di attivi, un terzo dei capitali mondiali. Il potere di ricatto di queste élite è tale che da una parte esse pretendono che i nuovi strumenti finanziari globali si autoregolino; d’altra parte quando è arrivata la crisi questi campioni del liberismo hanno convinto i governi a curare le loro ferite, mentre le famiglie dei lavoratori si vedevano pignorare le case. Queste élite guadagnano miliardi comunque, sia che i mercati vadano su o che vadano giù. I 1.100 capitalisti più ricchi del mondo controllano una ricchezza superiore a 2,5 miliardi esseri umani”. Che ci sia un problema di distribuzione della ricchezza è di una tale evidenza che persino Bill Gates e Warren Buffet, le cui ricchezze personali equivalgono a quelle di circa 280 milioni di poveri, si sono sentiti in dovere di dedicarsi alla filantropia.
Se basta tagliare un poco le spese militari per sradicare la fame e la povertà, perché questo non accade? I vertici decisionali sono sempre più lontani e si allontaneranno sempre di più. Inutile rincorrerli. Si sa che i “poteri forti”, nel mondo, sono talmente forti da essere incontrollabili. Le democrazie possono, bene che vada, controllare i loro delegati al tavolo extraterritoriale, e dunque non democratico, di questi poteri. Possono scegliere, votando, chi inviare a quel tavolo per prendere ordini. Ciò che dovrebbero poter fare le popolazioni abbienti è imporre il rispetto degli impegni presi dai loro governanti, dai poteri che sono loro più vicini, secondo le “regole della democrazia”. Come? Qui si apre una sorta di abisso della prassi. Un tempo, scioperi e manifestazioni, arrecando un danno notevole alle economie, avevano una certa “efficacia contrattuale”, non solo per le rivendicazioni salariali. Adesso no. Il mercato del lavoro ha reso imbelli e inermi i lavoratori, più che mai “merci”, sostituibili in brevissimo tempo con merci meno costose. Il cerchio sembra chiudersi inesorabilmente, poiché le dimensioni della povertà mondiale consentono di trascurare qualsiasi protesta o richiesta: ci sono miliardi di persone pronte o costrette a lavorare per quasi nulla, o per nulla. Facile rassegnarsi.
Rassegnazione. Chi si rassegna? Chi è il soggetto del rassegnarsi? Non può essere chiunque. Tanto la rassegnazione è soggettiva, del soggetto, quanto sono diverse le condizioni, le cause che possono indurre a rassegnarsi o a non rassegnarsi.
A che cosa ci si può o ci si deve rassegnare? Da quale visione del mondo si guarda la rassegnazione, come costrizione o come scelta? La visione del mondo è condizionata dal dove e dal come ci si trova a vivere. L’eventuale rassegnazione di chi sta morendo per fame non è equiparabile, e forse nemmeno accostabile, alla rassegnazione di chi, nei luoghi abbienti e ipernutriti del pianeta, si abbandona al disincanto. (Non è “facile retorica”. Ridurre a “retorica” il dolore è funzione benissimo svolta dai funzionari della “comunicazione di massa”; poi qualche intellettuale raffinato se ne adonta, magari adducendo questioni di “gusto”, come se si trattasse di parole o di immagini “estetiche” e non di vite reali).
Si vive, chi vive in agio, nella rimozione costante del tragico, delle tragedie: al plurale, una per ogni vita che soffre. È sempre stato così, dirà qualcuno. O: sono cicli della storia, dirà qualcun altro. Saggi entrambi. Ma questa saggezza non rende meno doloroso il dolore di chi soffre, e andrebbe messa alla prova rivolgendola, faccia a faccia, a qualcuno che subisce torture, a un bambino mutilato da una mina. I saggi non lo faranno. Diranno, magari, che “così è la vita”, c’è chi è vittima e chi no, chi ha e chi non ha fortuna. Oppure, un saggio di fede storicista dirà che si tratta di “necessità storica”, e un saggio di fede religiosa che il dolore sarà premiato nell’al di là con un’eterna vita felice.
Sappiamo ormai che l’avvento del cosiddetto postmoderno, la “fine delle grandi narrazioni” ideologiche, ha coinciso con l’avvento di una macroideologia poi definita “pensiero unico”. Al giorno d’oggi, molti di coloro che negli anni Ottanta e Novanta esaltavano o comunque assecondavano quel pensiero, coincidente con una concezione del libero mercato come unica possibilità di organizzazione sociale, cominciano a dubitare o addirittura a denunciare gli effetti nefasti, devastanti, del libero mercato stesso. Nel frattempo, il mito del comunismo sovietico è crollato insieme al muro berlinese. Nel frattempo, l’economia totalitario-liberista cinese è diventata sempre più forte (per chi lo dimenticasse, in Cina producono anche e soprattutto le transnazionali dell’Occidente, avvalendosi di mano d’opera schiavizzata nei campi di lavoro o a costi bassissimi). Nel frattempo, gli effetti che il libero mercato aveva prodotto nel “sud del mondo” si stanno manifestando anche nel “nord”. Tranne che per pochi, “la festa è finita”. Era una festa per pochi anche prima, ma chi alla festa partecipava si sentiva in dovere di non intristirla rammentando ai festaioli che la ricchezza di cui godevano era, letteralmente, bottino di guerra, di una guerra spietata e occultata: quella, appunto, del “libero mercato”.
Ma la “fine delle ideologie” portò con sé anche una nuova possibilità di pensiero: il poter pensare senza certezze. L’incertezza non è una condizione necessariamente negativa. Anzi, è forse l’unica condizione che ci è consentita, se non decidiamo di accecarci. L’incertezza sul “senso” della vita o sul futuro, sul “fine della storia”, non comporta la “fine della storia” (come si disse, sempre da parte di chi la storia in atto non la subiva). L’incertezza non implica l’abbandono di ogni “giudizio”. Anche senza credere in qualche paradiso, qui o nell’al di là, si può capire, o almeno sentire, che non è eticamente giusto fare ad altri ciò che non si vorrebbe venisse fatto a noi. E tuttavia, dalle nostre parti, questa condizione di incertezza scatenò soprattutto pulsioni “edonistiche”, pseudorelativismi intesi a giustificare la condiscendenza, moti di appropriazione dell’appropriabile senza più doversi porre il problema della “giustizia”. Poi ma questo è rilevante soltanto per le nostre miserie culturali alcuni fautori osannati del “pensiero debole” o del prevalere delle interpretazioni sui fatti si sono ricreduti, vedendo che il mondo andava in una direzione che, poveri loro, li smentiva.
Eppure i morti per fame, per guerra, per tutte le violenze al giorno d’oggi più evidenti anche a chi non voleva vederle prima, prima c’erano, e non erano occulte, per quanto occultate. Bastava volerle guardare. Bastava “mettersi nei panni”, mettersi nel corpo, nell’esistenza di chi un’esistenza non poteva averla, di chi esisteva soltanto per nutrire le esistenze di chi non voleva nemmeno sapere da dove gli veniva il cibo che lo stava ingrassando.
Il passato degli anni Ottanta e Novanta è un passato trascorso nella rimozione del passato precedente, e non tanto di quello ancora “rivoluzionario” dei decenni Sessanta e Settanta, ma soprattutto di quello in cui, come diceva Hannah Arendt, accadde “ciò che non doveva accadere”: lo sterminio dei campi nazisti, Hiroshima e Nagasaki, e i milioni di vittime dei regimi sedicenti comunisti, pur denunciati mostrati, per ciò che erano, a chi voleva guardare già dai primi anni Venti. Il Novecento è passato, con il suo orrore e le sue costanti rimozioni. Ma orrori e rimozioni non sono passati. Il passato non passa finché non lo si conosce, finché non lo si pensa. Forse, anche, finché non lo si cambia.
Rassegnarsi oggi vorrebbe dire rassegnarsi al dominio della logica economica, ovvero all’interesse di pochissimi che condiziona l’esistenza di tutti. Rassegnarsi allo spadroneggiare, in senso proprio, di quattro o quattromila “operatori finanziari” che possono, da un giorno all’altro, impoverire milioni di persone, o ai mercanti di armi e di petrolio che si arricchiscono sia con il petrolio che con le guerre per il petrolio. Dopo millenni, la tanto “umanista” cultura occidentale è finita con l’adorare, più di quanto avesse mai fatto, la triade denaro-potere-successo. Le ancor più antiche culture orientali stanno facendo altrettanto.
Ma rassegnarsi non è uguale per tutti. Se giusta può essere la rassegnazione, la rinuncia, rispetto a questi “valori” (denaro, potere, successo), lo è soltanto in negativo, negandosi a ciò che già ci viene negato: la possibilità di cambiare. La rassegnazione “opulenta” deriva quasi soltanto dal senso di impotenza di fronte alla distanza dei poteri, alla loro intangibilità. I poteri contro i quali si lottava negli anni Sessanta e Settanta erano poteri vicini e visibili, o almeno così si credeva, mentre adesso sono lontani e visibili soltanto nella loro apparenza ingannevole. Non potendo incidere sul “tutto”, si rinuncia a cambiare anche il “poco”, quello che dipenderebbe, ancora, da noi, dalla nostra volontà, dalla nostra responsabilità.
Ma rassegnarsi continua a non essere uguale per tutti. Anche la rassegnazione è un lusso. I milioni di bambini che muoiono di fame e di violenza e di schiavismo non possono rassegnarsi, non sanno nemmeno che cosa significhi, rassegnarsi. Spalancano gli occhi, soltanto, e dentro c’è il buio del loro dolore e fuori il buio di chi non vuole guardarli.
È sempre stato così, dirà il solito saggio. Millenni di “progresso”, allora, a che cosa sono serviti? Soltanto a sapere che “è sempre stato così”, che sarà sempre così?
Il progresso… È stato ed è tuttora il mito culturale più devastante. Si continua a credere che possa esistere qualcosa come il “progresso” indipendentemente da chi lo “fa”. E a farlo sono gli uomini. Dalla conquista prometeica del fuoco a quella della bomba atomica. Dalla lotta contro la natura “matrigna” alla sua “progressiva” distruzione. Per “avere” che cosa? Miliardi di uomini che non hanno nulla e pochi che non sanno, letteralmente, dove spendere il troppo che hanno (c’è chi, ad esempio, affitta jet privati, con fodere di visone, a tremila euro l’ora, magari sorvolando, compiaciuto, la discarica di una megalopoli brulicante di affamati). Per “essere” che cosa? Miliardi di uomini che possono soltanto cercare di sopravvivere e pochi che credono di “essere” perché hanno “vinto”, perché sono al di sopra della “massa morente”. La loro vita, oltre che nel consumare tutto il consumabile, consiste soltanto in questo: “avercela fatta”. L’abominevole “sogno americano” è diventato incubo mondiale. Quattro immagini sui morti di fame e poi un bel reportage sul menu consumato dai potenti nelle loro dimore. Così va il mondo…
Certo, questi non sono pensieri “filosofici”. Ma forse sono pensieri che ognuno dovrebbe pensare, ognuno di coloro che possono permettersi di farlo. Chiedendosi, ad esempio, se davvero si debba sempre rincorrere la corsa, se si debba sempre correre, verso un avanti che non si sa che cosa sia né dove possa arrivare. Cambiare il futuro sembra impossibile, e allora ci si lascia risucchiare nel “processo”, nel procedere. Ma la fede nel futuro è, tutto sommato (sommando tutto quello che la nostra specie ha fatto nel corso della sua storia), una fede abbastanza recente e quasi sempre smentita dai fatti. Affidandosi al futuro ci si è affidati al passato, all’homo homini lupus, che adesso trionfa.
2.
Denique avarities et honorum caeca cupido
quae miseros homines cogunt transcendere finis
iuris et interdum socios scelerum atque ministros
noctes atque dies niti praestante labore
ad summas emergere opes, haec vulnera vitae
non minimam partem mortis formidine aluntur.Lucrezio, De rerum natura, III, 59-64.
Limiti. Si dice che tutto è opposizione: bene-male, vita-morte, gioia-dolore, pace-guerra Si dice bene o male? L’opposizione vita-morte deve avere come corollario anche l’opposizione pace-guerra? Vita e morte sono davvero opposte? Se non si morisse, i viventi, eterni, quanti potrebbero essere, essere stati? La morte “libera spazio” per la vita di altri. Un fautore della guerra potrebbe allora aggiungere che, appunto per questo, occorrono guerre, ogni tanto, per “liberare spazio”, Lebensraum. Si sente di nuovo parlare di guerra come “igiene del mondo”, e forse non è soltanto una battuta da rassegnati
Accettare che nella vita ci sia la morte, che ne sia parte non solo ineliminabile ma anche fertile, e accettare che nella vita ci sia dolore, non comporta accettare che il “male” prevalga, che la guerra di tutti contro tutti sia anch’essa ineliminabile. Forse lo è. Ma soltanto pensando che non lo sia si può cercare di contrastarla. Pensando che lo sia, si pensa di avere, “come tutti”, il diritto a combattere “contro tutti”.
Poiché dobbiamo morire, poiché sentiamo e sappiamo di essere parziali, incompleti, separati e separandi, ci vendichiamo della nostra limitatezza fingendoci autonomi e completi e aggredendo chi ci rammenta, esistendo, che non lo siamo. Ci vendichiamo della nostra mortalità uccidendo, dando la morte.
Siamo esseri limitati, delimitati da nascita e morte, dalla sessualità che ci rende parziali e incapaci di riprodurci “da soli”. Eppure sembriamo voler imitare, anche nelle esistenze, il principio economico dello sviluppo illimitato, la cui irrazionalità si scontra contro evidenze sempre più catastrofiche. Nelle società abbienti sono ricomparsi i miti dell’eterna giovinezza e dell’ermafrodito. La scienza sembra promettere immunità dal trascorrere del tempo e indipendenza da ogni relazione umana che non sia strumentale, utilitaria. Gli altri, sempre di più, sono soltanto rivali, avversari, concorrenti da battere nella conquista dei pochi posti a disposizione nel paradiso della “superclasse”, dove si coabita mescendosi veleni a vicenda.
Cambiare il passato. In certe culture (lo si può leggere ad esempio nel Corano) il futuro viene immaginato alle nostre spalle, non davanti a noi. Davanti a noi c’è il passato. Soltanto del passato possiamo sapere qualcosa. E forse è il passato che dobbiamo cercare di cambiare.
E cambiare il passato forse non è così assurdo come potrebbe sembrare. La logica causa-effetto domina ancora la nostra cultura. Le cause vengono prima, e per evitare certi effetti occorre agire sulle cause. Si è invece agito sempre sugli effetti, e dunque, quasi sempre, non si è agito. Secondo il credo marxista, ad esempio (ed è un esempio che attiene a quasi tutto il sedicente anticapitalismo novecentesco), il “male” capitalista avrebbe causato, come effetto, il “bene” comunista. E tuttavia questo “bene” occorreva “organizzarlo”, “dirigerlo”, imponendo il capitalismo là dove ancora non si era manifestato nelle sue forme “moderne” (Russia, Cina, etc.). Il paradiso sarebbe arrivato ma prima bisognava passare, dopo l’inferno feudale, dall’inferno capitalista, per “sviluppare i mezzi di produzione”. A questo scopo occorrevano misure repressive molto severe, occorreva sacrificare alcuni milioni di persone, ma poi… A parte le chiacchiere “filosofiche”, questo è accaduto. A parte la fede nella “necessità storica”, il “sacrificio” della Spagna portò al massacro della seconda guerra mondiale. A parte le chiacchiere neoliberiste degli anni Ottanta e Novanta sullo “sgocciolamento” (trickle down, si diceva: la ricchezza che “sgocciola” dai ricchi ai poveri), i poveri sono aumentati (anche i ricchi, dirà qualcuno, ma in una proporzione che non ha ristretto la “forbice”: la distribuzione della ricchezza è infatti sempre più iniqua). A parte il parziale “arricchimento” di alcuni milioni di cinesi e di indiani, tutti gli altri indiani e cinesi vivono, se vivono, di “gocce” quasi invisibili e che costano, ognuna, litri di “sudore e sangue”.
I proclami degli organismi internazionali per abolire la povertà, che scivolano verso il futuro di decennio in decennio, nell’indifferenza per i milioni di persone che nel frattempo muoiono, corrisponde alla “commozione” mediatica, allo “spettacolo” della povertà e delle guerre alternato alle cronache rosa e nere.
Rassegnarsi al dominio di pochissimi, all’uso quasi solo propagandistico-ipnotizzante della cultura, ormai quasi tutta “di massa”, o “pop”, che cosa comporta? Che cosa comporta la complicità, magari fingendo di “voler cambiare dall’interno la macchina del potere”? Cosa comporta il silenzio: tacere, non agire, osservando il naufragio, fino a quando diventeremo naufraghi noi, o fino a quando non ci impietrirà lo sguardo di un naufrago, una Medusa sconfitta e non meno di noi desiderosa di “rassegnarsi al benessere”?
I miti del progresso e dello sviluppo economico infinito deresponsabilizzano il soggetto, che può abbandonarsi all’egoismo proprietario e accumulante.
Finalismi e teleologie, soteriologie e palingenesi, determinismi storici, economici e scientifici: tutto si tiene, nell’ansimante ricerca di un altrove temporale che consenta di vivere il presente della propria vita senza dover scegliere e, ancor più, senza voler scegliere. Anche la volontà, infatti, è un privilegio. E poiché non tutti possono volere, anche nel non volere c’è una responsabilità.
In un antichissimo testo mesopotamico si dice che se l’uomo fosse davvero cattivo la specie sarebbe scomparsa da tempo. Allora, gli strumenti, le armi, per far scomparire la specie erano però soltanto quelli dell’aggressione fisica ravvicinata, guardandosi negli occhi. Adesso si può, novelli Apolli, “colpire da lontano”, anche da lontanissimo, senza aver mai negli occhi lo sguardo delle vittime. Adesso si può uccidere divorando risorse e distruggendo l’ambiente senza muoversi dal proprio ufficio: bastano computer e telefoni. E tuttavia anche i predatori più feroci, i più accaniti sostenitori del loro proprio presente a danno del presente e del futuro altrui, sembrano avere un residuo di ciò che un tempo si chiamava coscienza, o devono ancora, quel residuo ipocrita, porlo ad insegna delle loro imprese. Ancora, nelle dichiarazioni formali, si propugnano bene comune, pari dignità e altri valori “buoni”, che pochi, a parole, si azzardano a contraddire esplicitamente, pur facendolo costantemente nei fatti. I demagoghi attuali dicono di agire per il “bene del Paese”, anche se agiscono per il bene loro. Sia i demagoghi che i loro seguaci ed elettori hanno ancora bisogno di questa finzione, di questa rappresentazione, che ha avuto di recente in Italia un ulteriore successo. (E lo ha avuto soprattutto grazie alla individuazione di un nuovo nemico, i nuovi “barbari” contro i quali affermare la propria identità, dai quali difendere il proprio “modo di vivere”. I soliti: gli stranieri, gli immigrati, i poveri. Gli specchi di ciò che può diventare chiunque da un momento all’altro, se “fallisce” nell’impresa della sua esistenza, se è incapace di imitare, sia pur in piccolo, l'”imprenditore sommo” che governa i suoi piccoli adoratori.)
Cambiare il passato può dunque significare agire sulle cause. Rifiutarsi di assecondare le “logiche” del potere, del denaro, del successo. Non solo rifiutare di sottomettersi ma anche di sottomettere altri. Non accumulare ricchezza, non consumare oltre il necessario. Non cercare il plauso mediatico, rifiutare che la propria identità possa identificarsi con l’apparire su televisioni e rotocalchi (ambizione suprema, ormai, di quasi tutti i giovani). Già questo “preferire di no”, secondo il metodo di Bartleby, sarebbe molto. E da questo agire secondo la responsabilità che ha ciascuno di noi anche se cerca continuamente di allontanarla da sé potrebbe forse scaturire un nuovo agire comune, un costruire insieme. Non più secondo il principio base del liberismo, secondo il quale dalla ricerca del benessere individuale nascerebbe il benessere sociale, ma dal suo contrario, dal mettere sempre al primo posto il bene altrui. Bisognerebbe provare a mettere in pratica ciò che andiamo dicendo da sempre, a cui diciamo di credere, anche soltanto nella forma egocentrica del “non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. Ciascuno secondo le sue possibilità e la sua responsabilità. Oppure dovremmo porre a sigillo del nostro dire e dire di credere ciò che, nell’agire, prevale: “fai ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. Rassegnati, e finalmente sinceri.
Giugno 2008
Published 12 February 2009
Original in Italian
First published by La Camera Verde, Rome (Italian version) / Wespennest 153 (2008) (German version)
Contributed by Wespennest © Giuliano Mesa / La Camera Verde / Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.